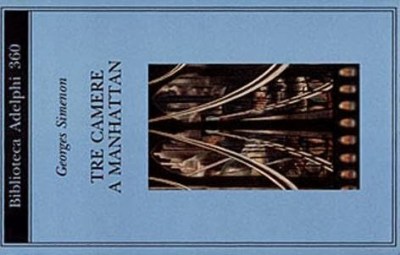Una volta li ho contati, erano più di
40, tutti messi in fila, uno appresso all’altro su un ripiano della mia libreria. Sto parlando dei libri di
Camilleri che ho comprato e letto (e adorato) negli ultimi
20 anni. Ultimamente m’ero un po’ stancato e da un annetto non lo leggevo più. Poi l’altro giorno mentre ero da
Feltrinelli per comprare un libro che mi aveva chiesto mia figlia, l’ho visto, e mi sono detto: è un “
Montalbano“, è sempre piacevole; e l’ho porto alla cassiera per metterlo in busta.
Prima nota stonata: il prezzo, 14 euro, mi è parso eccessivo. Fino a poco tempo fa costavano 10, siamo al 40% in più, non è poco. D’accordo, quello dell’editoria è un mercato come tutti gli altri (ma anche no, ma qui si aprirebbe una voragine discorsiva), ma soprattutto in tempi di crisi, certi aumenti hanno un forte sentore speculativo. Come quelli dei petrolieri o delle compagnie assicurative, inutile inveire contro quest’ultimi allora, è la legge della domanda e dell’offerta, ciascuno la applica come può, per tutti gli altri l’intramontabile Legge del Menga.
Seconda cosa che mi ha subito colpito: il linguaggio. Dall’italiano frammisto a termini siciliani o siculamente distorti, Camilleri è passato al puro dialetto, anche per la voce narrante, dove non sarebbe strumento di definizione di un personaggio (Catarella, tanto per dire, parla giustamente come Catarella), quindi non indispensabile. Camilleri stesso, in un intervista in TV, ha dichiarato che il suo siciliano non esiste, è piuttosto una sorta di trasposizione letteraria di ciò che è il dialetto siciliano nell’immaginario dei non siciliani. Questa scelta, però, intralcia la lettura, vuoi perché si moltiplicano i termini di significato sconosciuto (e lo dice uno che ha passato le estati della propria infanzia in Sicilia), vuoi perché i dialetti in genere sono di difficile trascrivibilità per i loro fonemi spesso biascicati. Si pensi alla “c” romanesca, spesso trascritta “sc“, in realtà intrascrivibile. Insomma, il passo della lettura inciampa inevitabilmente, sottraendo conseguentemente fluidità alla lettura.
Ciò premesso, il racconto si sviluppa sul plot solito, la griglia è sempre la stessa, gli eventi si susseguono secondo uno schema arcinoto a chi è avvezzo alla lettura di Montalbano. Anche le gag sono le solite: le sciarriatine con Livia, i pizzini didascalici di Fazio, il cinismo del dottor Pasquano, le papere di Catarella e via discorrendo. Il punto è che in tutto questo contesto pare mancare la sostanza. I guizzi di genialità che contraddistinguono molti dei libri dei Camilleri, “Privo di titolo” tanto per citarne uno, proprio non ci sono. Resta solo un cliché già noto che finisce per far diventare Montalbano & company una caricatura di loro stessi e l’autore un epigono di ciò che fu. Solo verso il finale le vicende assumono un po’ di vigore, colorando una trama che per molte pagine è stata piuttosto scialba, anche se attraverso il solito coinvolgimento della politica più alta, lasciato intravedere nelle prime pagine; fatto, anche questo, già visto molte volte sugli stessi schermi.
Tutto questo pensavo durante la lettura, che è comunque scorsa rapida nelle ultime 24 ore, fra una seduta mattutina in vasca da bagno ed un paio di viaggi in metro; poi invece, arrivato all’ultima pagina, leggo una nota che avverte che si tratta di un libro scritto anni prima e non pubblicato. Effettivamente alcuni dei riferimenti, per nulla velati, alla situazione politica italiana si rifanno ad avvenimenti non recentissimi. Ma davvero è uno scritto ripescato dal fondo di un cassetto di casa Sellerio? A pensar male si fa peccato, però… La nota spiega che si tratta di “misteriose alchimie editoriali“, forse è solo un libro meno riuscito di altri tenuto in serbo per i momenti di stanca. D’altra parte da tempo c’è chi insinua che ci siano diverse penne dietro la medesima firma, dietro una produzione così intensa; io mi associo alla schiera dei dubbiosi. Dubbioso anche, e molto, di comprare il prossimo che pubblicherà. Come dite? Ne è uscito un altro proprio stamattina? Naaaaaa!